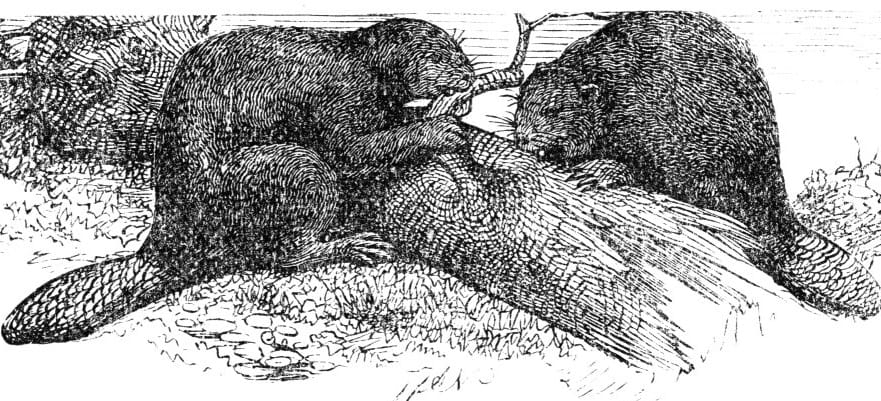Il castoro europeo (Castor fiber) sta facendo un sorprendente ritorno nel panorama faunistico italiano dopo ben cinque secoli di assenza. Questo grande roditore, che era stato dichiarato estinto nel territorio italiano durante il XVI secolo, rappresenta oggi un affascinante caso di ricolonizzazione che merita particolare attenzione.
La scomparsa del castoro dall’Italia fu principalmente dovuta all’eccessiva pressione venatoria. Questo magnifico animale era molto apprezzato per diversi motivi: la sua pelliccia, le carni considerate prelibate e soprattutto per il “castoreum”, un secreto oleoso prodotto dalle ghiandole perianali. Questa sostanza, dal caratteristico odore intermedio tra il cuoio e la vaniglia, era particolarmente preziosa sia per scopi medicinali che per l’industria profumiera. Il castoreum è ricco di acido salicilico, che l’animale estrae naturalmente dalle cortecce di salice di cui si nutre. Veniva utilizzato come una sorta di aspirina ante litteram e, grazie al suo profumo caldo e animale, era molto richiesto per la produzione di profumi e deodoranti maschili. Il grande valore commerciale di questi prodotti ha portato a una caccia intensiva che, combinata con la distruzione degli habitat fluviali, ne ha determinato l’estinzione in gran parte d’Europa.
Negli ultimi anni, il castoro europeo ha iniziato a ricolonizzare il territorio italiano attraverso diverse vie. A partire dall’autunno 2018, i primi esemplari sono stati avvistati in Friuli Venezia Giulia (Tarvisio), seguiti da presenze in Val Pusteria (Alto Adige) nel 2020 e successivamente in Piemonte e Lombardia. Questi animali provengono dalle popolazioni reintrodotte con successo in Austria tra gli anni ’70 e ’90 del secolo scorso e in Svizzera tra gli anni ’50 e ’70. La capacità di dispersione dei castori è sorprendente, potendo raggiungere i 200 km all’anno.
Parallelamente, e qui entriamo nel regno dell’avventura notturna, alcuni “benefattori della biodiversità” hanno pensato bene di dare una mano alla natura con qualche reintroduzione fai-da-te. Come in un’operazione di contrabbando naturalistico degna di un film di spionaggio, sono apparsi misteriosi nuclei popolazionali nell’Italia centrale. Questi gruppi di castori “clandestini” sono già riproduttivi e ben stabiliti in Toscana (tra le province di Siena, Arezzo e Grosseto), in Umbria, nel Lazio (Valtiberina) e in Campania (fiume Volturno). Evidentemente questi eco-attivisti notturni non hanno resistito alla tentazione di accelerare i tempi della natura, dotando i fiumi italiani di nuovi ingegneri idraulici senza passare per noiose pratiche burocratiche o valutazioni scientifiche. Chissà se hanno lasciato anche un biglietto di benvenuto ai loro ospiti a quattro zampe!
Mettendo insieme tutte le attuali conoscenze, la popolazione di castori in Italia sta crescendo rapidamente e ha probabilmente già superato la cinquantina di esemplari, tra immigrati legali e “sans papiers”.
Il castoro è considerato un vero e proprio “ingegnere ecosistemico”, capace di modificare notevolmente gli habitat in cui vive. La sua attività di costruzione di dighe crea specchi d’acqua a corso rallentato che hanno un impatto generalmente positivo sulla biodiversità locale. Questi ambienti favoriscono la presenza di rare specie di anfibi, pipistrelli, piccoli mammiferi e piante acquatiche, altrimenti relegate a torbiere e zone umide sempre più rare. La letteratura scientifica internazionale evidenzia anche come le modifiche imposte ai corsi d’acqua dall’attività dei castori abbiano una funzione essenziale nella regimazione delle acque, particolarmente importante in tempi di crisi idrica.
Se da una parte il ritorno del castoro rappresenta un segnale positivo per la biodiversità, dall’altra potrebbe generare alcuni conflitti con le attività umane. I principali impatti riguardano la riduzione della stabilità spondale dei corsi d’acqua, che in zone agricole o urbane “pensili” può aumentare il rischio di allagamenti, possibili danni alle coltivazioni arboree attraverso l’attività di rosicchiamento e potenziali interferenze con canali artificiali, strade e ponti a causa della costruzione di dighe e tane. Le aree di potenziale conflitto sono principalmente distribuite nell’Italia centrale (Toscana, Umbria e Marche) e in Trentino Alto Adige, mentre appaiono più limitate in Friuli Venezia Giulia.
Dal punto di vista normativo, la situazione del castoro in Italia è particolare. La specie è protetta a livello europeo dagli Allegati II e IV della Direttiva Habitat 92/43 CEE. In Italia, pur non figurando esplicitamente tra le specie protette dalla Legge Nazionale 157/92 (poiché nel 1992 era considerata estinta), è di fatto tutelata da questa legge, che considera protette tutte le popolazioni animali presenti in natura.
Qui si apre un curioso paradosso burocratico: le popolazioni “abusive” dell’Italia centrale, frutto di reintroduzioni non autorizzate, dovrebbero tecnicamente essere eliminate secondo le indicazioni dell’Associazione Teriologica italiana e dell’Ispra. Una sorta di “espulsione” di immigrati irregolari nel regno animale. Tuttavia, l’ipotesi di procedere con questa rimozione appare estremamente remota, sia per la complessità logistica (coinvolgendo numerose regioni) sia per precedenti legali. In casi simili avvenuti nella Penisola Iberica, l’Unione Europea ha concesso un certo lasso di tempo per eliminare le popolazioni costituite illegalmente, ma trascorsi 15 anni senza completare l’eradicazione, ha imposto la protezione degli animali rimasti. In pratica, dopo un periodo di “clandestinità”, i nostri amici rosicchianti potrebbero ottenere una regolarizzazione forzata, una sorta di sanatoria ecologica che farebbe sorridere molti politici italiani.
Il destino delle popolazioni italiane di castoro resta comunque incerto, sia per il ridotto numero di fondatori nelle regioni settentrionali, sia per l’origine illegale delle popolazioni centro-meridionali, di cui non si conoscono origine e stato sanitario. Secondo gli “esperti”, sarebbe necessario un attento monitoraggio nelle zone più a rischio, per poter applicare prontamente misure di gestione che possano mitigare i possibili danni, come la protezione dei campi agricoli con recinzioni e il drenaggio controllato delle aree umide create dai castori quando minacciano infrastrutture umane.
Nonostante le sfide e le modalità talvolta discutibili del suo ritorno, la presenza di questo grande roditore rappresenta una straordinaria opportunità per riscoprire e valorizzare la biodiversità italiana. La sua funzione ecologica di moltiplicatore della biodiversità fluviale è tale che, superati i problemi iniziali di adattamento e gestione, l’espansione naturale potrebbe essere favorita con iniziative parallele di monitoraggio e valorizzazione dell’habitat. Dopotutto, dopo cinque secoli di assenza, il castoro europeo merita forse una seconda possibilità nel Bel Paese, che arrivi con documenti in regola o con un passaporto un po’ più creativo.
(Autore: Paola Peresin)
(Foto: Wikipedia)
(Articolo di proprietà di Dplay Srl)
#Qdpnews.it riproduzione riservata